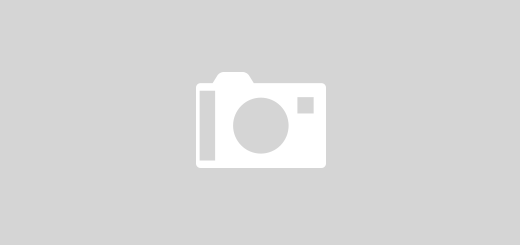Ben più di un anno fa avevo provato a tracciare una definizione di Social Business non tanto come sostituzione quanto come allargamento del concetto storico di impresa rispetto alle nuove dinamiche del mercato ed ai nuovi comportamenti sociali del consumatore:
“Un’organizzazione che ha messo in campo le strategie, le tecnologie ed i processi atti a coinvolgere sistematicamente tutti gli individui che compongono il proprio ecosistema (dipendenti, clienti, partner, fornitori) nella massimizzazione del valore scambiato”
Nella definizione si volevano sottolineare in modo particolare alcuni aspetti sostanziali come il confine poroso dell’azienda, la distribuzione del potere decisionale a tutto l’ecosistema tramite il meccanismo del coinvolgimento e specialmente un nuovo obiettivo dell’impresa: lo “scambiare” e, non più solamente, il generare valore.
Cosa significa però scambiare? Come si realizza questo processo? E ancora di più, qual è il ruolo del Social Business rispetto al sociale inteso alla Muhammad Yunus come entità finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che conti per la collettività? C’è un qualche collegamento o si tratta, come rimarcato negativamente da molti, di due significati diversi attribuiti alle stesse parole?
Queste domande mi sono tornate alla mente grazie ad una discussione in Facebook sull’ormai tristemente noto caso OMSA, azienda del gruppo Golden Lady Company che a fine Dicembre ha deciso di licenziare 239 lavoratrici del sito produttivo di Faenza per spostare il lavoro più a basso costo in Serbia. In risposta alla decisione dell’azienda di portare la produzione fuori dall’Italia, pur non trovandosi di fronte a problemi economici, la rete si è mobilitata attaccando in modo molto duro la Golden Lady nei suoi canali ufficiali, lanciando decine di gruppi di protesta e sostenendo iniziative di boicottaggio con più di 100K utenti coinvolti. Video ed interviste sulla questione hanno fatto il giro della rete e le lavoratrici sono comparse nei maggiori telegiornali ed a Servizio Pubblico da Michele Santoro.
Alcune domande contenute nel thread su Facebook erano:
- Come gestire una crisi nei social media che origina da una situazione oggettiva, sostanziale, con forti ripercussioni sulla vita di centinaia di persone? E’ sufficiente far finta di niente ed attendere che le acque si calmino?
- Si può pretendere di essere sociali online pur trattando i propri dipendenti in questo modo? Con quale costo?
- C’è qualche lezione più profonda, più generale che il caso OMSA dovrebbe insegnare a chi si avvicina al Social Business?
Non ho studiato a fondo i risvolti legali, contrattuali ed economici del caso OMSA. Non rientra del resto nel mio ruolo decretare se il comportamento dell’azienda sia corretto o meno. Ciò su cui vorrei invece portare la vostra attenzione è il costo complessivo nel lungo termini che simili azioni introducono sul piano del valore scambiato.
In una visione classica del capitalismo da una parte c’è l’azienda, interessata unicamente a massimizzare il proprio profitto, dall’altra la società che è spesso costretta a pagare il conto sociali di questa azione in termini di consumo di risorse naturali, sostegni economici agli individui in difficoltà, recupero delle tasse evase, punizione di comportamenti non etici di sfruttamento della manodopera. L’inconciliabilità tra risultati a breve termine dell’impresa e progresso sociale è qualcosa di talmente connaturato alla nostra esperienza dall’essere sanzionato da molti governi tramite leggi e tasse tesi a far scontare alle imprese le ricadute delle proprie azioni sulla società. E’ proprio a causa di decenni di comportamenti simili, magari legali, ma eticamente riprovevoli, che la fiducia tra imprese e consumatori si è ridotta al lumicino.
Ma è davvero questa l’unica forma di capitalismo possibile? Non secondo Michael Porter e Mark Kramer che in un articolo di Gennaio 2011 su HBR ridefiniscono l’obiettivo dell’impresa tramite il concetto di Valore Condiviso:
“Le policy e le pratiche operative che migliorano la competitività di un’azienda migliorando, allo stesso tempo, le condizioni economiche e sociali delle community in cui opera”
In altri termini, Porter e Kramer allargano i confini del capitalismo offrendo una via che al contempo ne rende possibile lo sviluppo e genera benefici per tutti gli interlocutori coinvolti. Invece che come un costo esterno, il valore condiviso viene proposto nell’articolo come unica leva sostenibile per rilanciare il futuro dell’impresa, farne ripartire la competitività e riconnetterla al benessere sociale.
A tal fine vengono discusse tre vie:
- Riconciliare prodotti e mercati – ovvero sviluppare prodotti e servizi che affrontino reali bisogni sociali (salute, sicurezza, realizzazione, accesso alle risorse da parte di comunità svantaggiate, etc)
- Ridefinire la produttività nella catena del valore – ovvero dimenticare la riduzione dei costi a breve termine e migliorare la produzione andando ad agire sulle condizioni dell’intero ecosistema che ruota intorno all’azienda (consumi di energia, riduzione delle distanze nella logistica, consumo di risorse naturali, supporto alla crescita dei fornitori, nuovi meccanismi di distribuzione, investire sui dipendenti, etc)
- Abilitare lo sviluppo di cluster locali – pur in un’era di grande virtualità, una produzione totalmente delocalizzata introduce costi non più sostenibili al crescere dei prezzi di carburante ed energia, ma sopratutto distrugge il legame tra azienda e comunità locale in termini di disponibilità di competenze, efficienza delle infrastrutture, richiesta dei prodotti, introducendo di fatto più costo di quanto non si risparmi delocalizzando.
Leggendo l’articolo a me si è accesa una lampadina.
Se il Social Business non fosse poi altra cosa rispetto al sociale in senso classico? Se la missione comune, pur se non del tutto sovrapposta, fosse il creare un mercato più a misura di essere umano, in cui l’obiettivo non è il profitto fine a se stesso, quanto la co-creazione e lo scambio di valore tra le parti? Se questa visione non fosse dettata dal buonismo, ma da un’ottica puramente economica di crescita ed ottimizzazione dei costi?
Il caso OMSA, anche se non ancora arrivato alla sua conclusione, mostra in modo lampante la difficoltà del modello attuale di impresa di far fronte ai devastanti, ma quotidiani, cambiamenti a cui siamo esposti. Cambiamenti non solamente economici, come al contrario Golden Lady sembra ritenere. Una visione pericolosamente esposta dai social media. Se finora la risposta scontata è stata quella di far ricadere il costo sull’anello più debole, ovvero le persone, in un panorama in cui grazie al social queste persone hanno una nuova leva per farsi sentire, aggregarsi su larga scala, far montare movimenti di opposizione, nel lungo termine simili decisioni di management potrebbero finire per danneggiare piuttosto che premiare l’impresa.
In particolare il lavoro di Porter e Kramer mi sembra dedichi troppo poco spazio a due componenti che nel “nostro Social Business” abbiamo invece imparato a trattare con il massimo rispetto e che potrebbero rivelarsi dimensioni chiave anche per OMSA:
- il potere della motivazione e del rispetto dei dipendenti
- la forza di aggregazione ed azione delle community
Che ci si occupi di no-profit o di profit, tutti noi abbiamo a mio avviso una missione sociale: aiutare le aziende ad avvicinarsi alle persone, siano esse dipendenti o clienti, smettendo di opporsi a questi ed al contrario imparando a meritarne e coltivarne la passione al fine di creare un valore ancora più grande e soprattuto condiviso.
Qualcosa che molte aziende sono ancora lontane dal comprendere pienamente.